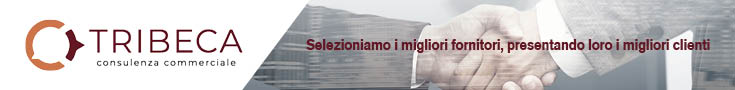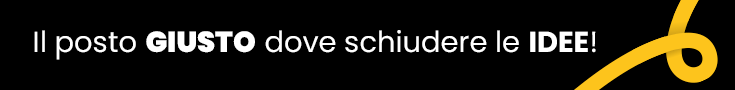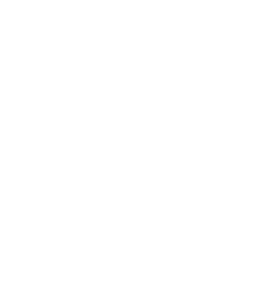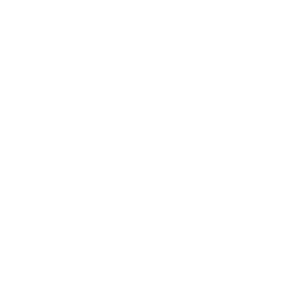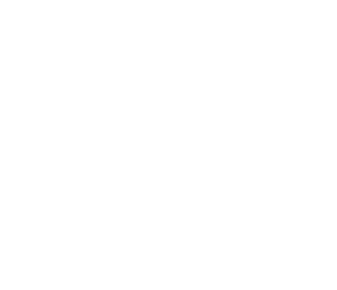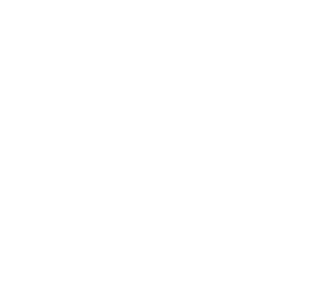La diplomazia ha concesso un altro anno di respiro, ma la partita sulle terre rare – i metalli che alimentano l’economia verde e l’industria militare – resta nelle mani della Cina.
L’intesa raggiunta a fine ottobre tra Pechino e Washington, che rinvia al 2026 le restrizioni cinesi all’export di materiali strategici, ha allentato le tensioni commerciali ma non ha risolto il problema di fondo: il controllo quasi totale del mercato globale da parte di Pechino.
La Cina detiene oltre il 90% della capacità mondiale di raffinazione e produzione di componenti chiave come i magneti permanenti, indispensabili per turbine eoliche, pannelli solari e veicoli elettrici. Una leadership industriale costruita in vent’anni e che oggi rappresenta una leva geopolitica potentissima. “La dipendenza dell’Occidente è un rischio reale”, ha commentato il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa, invitando Pechino a garantire “catene di approvvigionamento stabili e trasparenti”.
Dietro i numeri si nasconde un paradosso: le terre rare sono essenziali per la transizione ecologica, ma la loro estrazione e lavorazione restano concentrate in un Paese che della sostenibilità fa un argomento di forza e, allo stesso tempo, di pressione politica. Secondo i dati presentati da Sky TG24 Numeri, ogni turbina eolica contiene circa 200 chili di terre rare, ogni pannello solare un chilo, e ogni auto elettrica mezzo chilo. Ma sono altrettanto decisive per il comparto militare: il 78% delle armi prodotte negli Stati Uniti – dai caccia ai sottomarini – contiene componenti derivati da questi minerali. In un sottomarino, ad esempio, se ne trovano fino a quattro tonnellate, mentre in un aereo militare circa 400 chili.
Gli effetti della guerra commerciale si fanno già sentire. I dazi americani sulle esportazioni cinesi hanno ridotto sensibilmente le vendite di magneti verso gli Stati Uniti, secondo i dati delle dogane di Pechino. Ma la creazione di una filiera alternativa resta lontana: per aprire una miniera servono fino a otto anni, mentre la costruzione di un impianto di raffinazione richiede dai cinque ai sette. È un percorso lungo, che Washington sta cercando di accorciare con accordi bilaterali con Australia, Canada e Giappone, ma che non potrà colmare in tempi brevi un ritardo ventennale.
Negli anni Novanta, gli Stati Uniti erano il principale produttore mondiale di terre rare. Poi, nel 2002, la chiusura delle miniere – considerata all’epoca una scelta economica razionale – ha spianato la strada alla supremazia cinese. Oggi gli USA coprono appena il 12,4% della produzione globale. In questo scenario, l’Europa è ancora più vulnerabile. Il 98% delle terre rare utilizzate nel continente proviene dalla Cina, e soltanto il 2% da altri Paesi. Bruxelles ha approvato un piano per incrementare l’estrazione e la lavorazione interne entro il 2030, ma gli obiettivi fissati restano modesti rispetto ai livelli di Pechino e Washington. Inoltre, la lentezza dei processi autorizzativi e i vincoli ambientali rendono improbabile un rapido aumento della produzione europea.
Il risultato è una dipendenza strategica che rischia di compromettere non solo la transizione ecologica, ma anche la sicurezza industriale e militare del continente. “Le terre rare sono il nuovo petrolio del XXI secolo”, osservano gli analisti: senza una strategia comune, l’Europa rischia di restare terreno di gioco, non giocatore.
Gloria Giovanditti