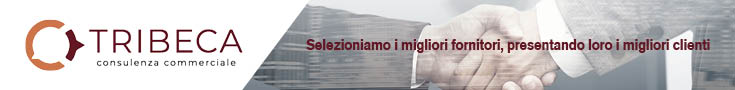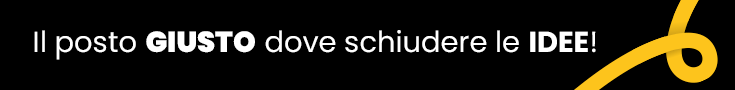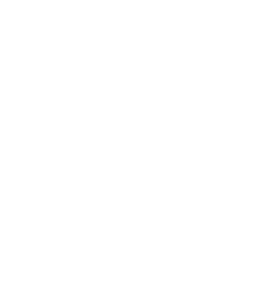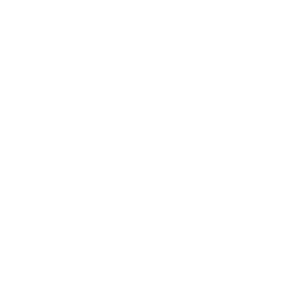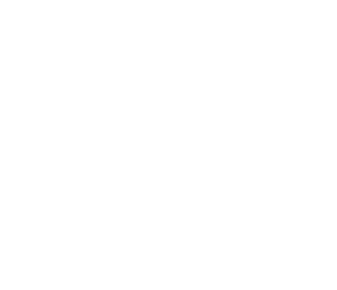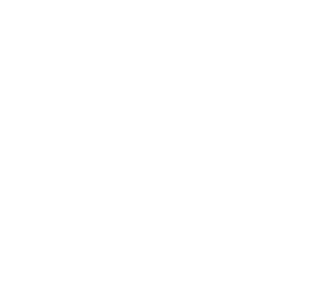Il Premio Nobel per l’Economia 2025 è stato assegnato a Joel Mokyr, Philippe Aghion e Peter Howitt “per aver spiegato i meccanismi dell’innovazione come motore della crescita economica”. Tre studiosi che, da prospettive diverse, hanno ridefinito il modo di interpretare lo sviluppo moderno e il ruolo del sapere nella prosperità delle nazioni.
L’Accademia Reale delle Scienze di Svezia ha riconosciuto a Mokyr, storico dell’economia e docente alla Northwestern University, il merito di aver dimostrato come le idee siano il vero carburante del progresso, più ancora del capitale o delle risorse naturali. Nei suoi studi, in particolare quelli dedicati alla Rivoluzione industriale, Mokyr ha mostrato che l’innovazione fiorisce solo dove esiste un contesto aperto, curioso e libero: società che favoriscono la circolazione della conoscenza, che non temono la scienza e che premiano la creatività invece della rendita.
L’altra metà del premio è andata a Philippe Aghion e Peter Howitt, protagonisti della cosiddetta teoria della crescita endogena. Nei loro modelli, l’innovazione nasce dal dinamismo delle imprese e dalla concorrenza, attraverso un processo di “distruzione creativa” — concetto reso celebre da Schumpeter — in cui le nuove tecnologie soppiantano quelle obsolete, alimentando cicli di sviluppo e produttività. Ma i due economisti hanno anche avvertito che quando il mercato si chiude, la concorrenza si riduce o le barriere all’ingresso aumentano, l’innovazione rallenta e la crescita si ferma.
“La crescita non è mai garantita, va coltivata”, ha commentato Aghion dopo l’annuncio del premio. Mokyr, da parte sua, ha messo in guardia dal rischio che politiche antiscientifiche o tagli ai finanziamenti pubblici possano compromettere la capacità di rigenerazione delle economie avanzate. Parole che risuonano con particolare forza in un momento in cui molte economie occidentali, Italia compresa, affrontano un rallentamento strutturale della produttività e un indebolimento del capitale umano.
Negli ultimi vent’anni, la crescita europea ha infatti perso slancio. Nonostante la rivoluzione digitale e la diffusione dell’intelligenza artificiale, la produttività del lavoro è aumentata molto meno rispetto ai decenni passati. Secondo gli analisti, il motivo è duplice: da un lato la frammentazione degli investimenti in ricerca e sviluppo, dall’altro la difficoltà a trasformare l’innovazione tecnologica in benessere diffuso. Le teorie dei tre premi Nobel forniscono una chiave per capire questo paradosso: l’innovazione non basta da sola, serve un ecosistema che la sostenga — fatto di formazione, concorrenza, libertà di impresa e fiducia nel sapere.
In Paesi come Francia o Germania, politiche pubbliche mirate hanno incoraggiato la nascita di imprese tecnologiche e startup ad alto contenuto scientifico. L’Italia, invece, resta indietro: investe meno dell’1,5% del Pil in ricerca e sviluppo, contro una media europea superiore al 2,7%. E mentre cresce la spesa in tecnologie digitali, il sistema produttivo continua a soffrire di bassa innovazione e scarsa valorizzazione dei giovani talenti.
Il Nobel 2025 assume quindi un significato che va oltre l’accademia: è un invito politico e culturale a rimettere l’innovazione al centro delle strategie economiche. Non come slogan, ma come visione strutturale. Perché — come dimostrano Mokyr, Aghion e Howitt — la crescita non è un dono automatico dell’economia, bensì il risultato di una scelta collettiva, di un Paese che decide di credere nelle idee e nel futuro.
Gloria Giovanditti