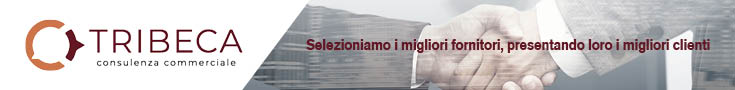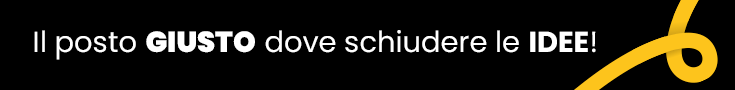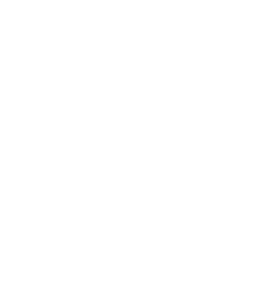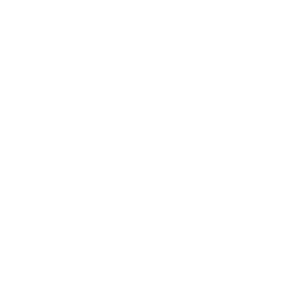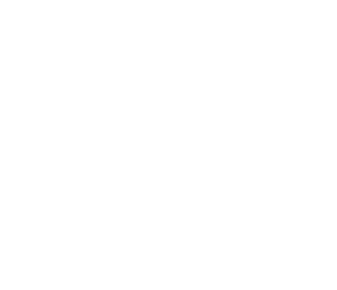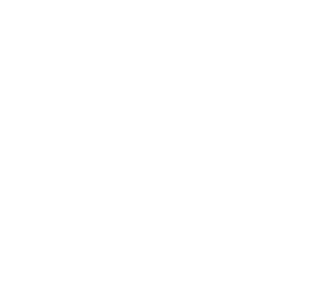Più della metà dei fondi pubblici destinati a collegare università, centri di ricerca e imprese non è ancora stata utilizzata. Dei 8,5 miliardi di euro del Pnrr stanziati per il trasferimento tecnologico, solo il 44% è stato speso. Un rallentamento che pesa su una delle leve strategiche per la competitività industriale italiana: la capacità di trasformare conoscenza scientifica in innovazione produttiva. Lo rileva la quinta Relazione sulla ricerca e l’innovazione in Italia, elaborata dal Cnr con il contributo dell’Area Studi Mediobanca, segnalando un sistema che, pur ricco di risorse, fatica a convertirle in risultati tangibili.
Il dato più rilevante riguarda la destinazione delle somme già impiegate: il 60% è servito a finanziare nuove assunzioni, con oltre 12.000 ricercatori entrati nel sistema pubblico, quasi una su due donna. Una spinta occupazionale che rafforza i poli accademici, ma lascia scoperto il fronte più atteso dal mondo produttivo: quello dei progetti con ricadute dirette sull’industria. A oggi i fondi si concentrano soprattutto su transizione digitale e aerospazio (30,3%) e su clima ed energia (20,6%), settori chiave per la modernizzazione ma non sempre in facile e diretta comunicazione con le Pmi e le filiere manifatturiere.
La rendicontazione dei fondi si concluderà solo il 31 dicembre 2026, e gli autori della Relazione prevedono che gran parte delle spese si concentrerà proprio negli ultimi mesi. Un’accelerazione finale che rischia di ridurre la qualità dei progetti e di spostare l’attenzione dall’impatto economico alla semplice conformità contabile. Per il tessuto imprenditoriale, la vera sfida sarà trasformare questi investimenti in partnership stabili, in brevetti e in tecnologie trasferibili alle imprese. Solo così il Pnrr potrà davvero generare un effetto moltiplicatore, capace di tradurre la ricerca pubblica in valore competitivo per l’economia italiana.