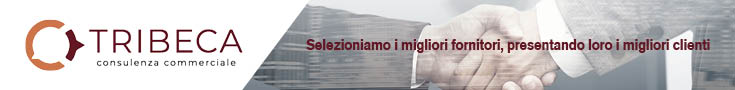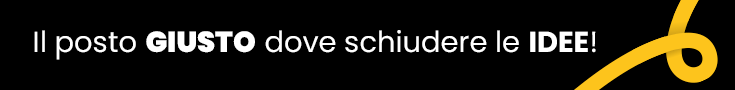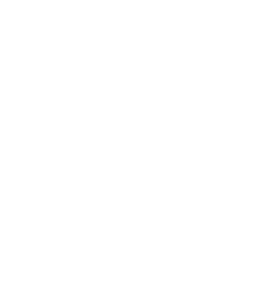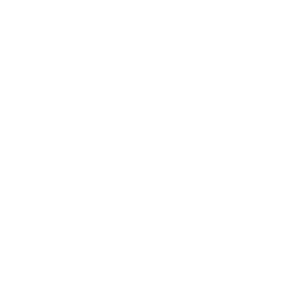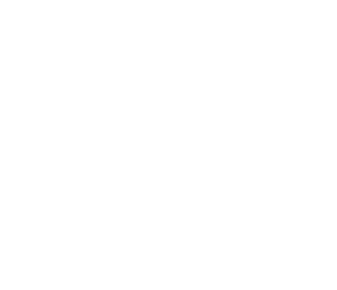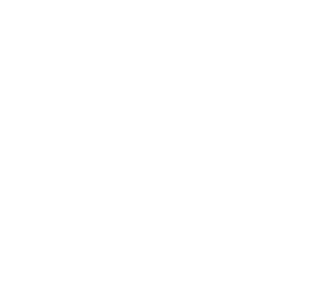Nel 2024 il mercato del lavoro italiano continua a mostrare un divario salariale profondo tra uomini e donne. Le rilevazioni dell’Osservatorio Inps sui lavoratori del settore privato non agricolo indicano che, a fronte di una retribuzione annua lorda media di 27.967 euro per gli uomini, le donne si fermano a 19.833 euro, cioè circa il 29% in meno. Una forbice che si mantiene costante negli anni e che non dipende solo dagli stipendi di partenza, ma da un insieme di fattori strutturali che pesano lungo tutto il percorso professionale femminile.
Uno di questi è la distribuzione settoriale. Le lavoratrici sono infatti concentrate in comparti tradizionalmente meno retribuiti: nell’istruzione, dove il 77% degli occupati è donna, il salario medio è di 12.000 euro, quasi la metà rispetto alla manifattura, settore con retribuzioni medie intorno ai 23.000 euro ma con presenza femminile al 29%. Anche la progressione di carriera resta limitata: nel 2022 solo il 21% dei manager era donna, una proporzione di circa una su cinque, segnale che le posizioni apicali rimangono prevalentemente maschili.
La disparità affonda però le sue radici anche nei percorsi formativi. Le lauree che garantiscono gli stipendi più elevati – dall’informatica all’ingegneria industriale – rimangono ambiti a forte prevalenza maschile. A cinque anni dalla laurea, in Informatica/ICT le donne sono appena il 18,5%, in ingegneria industriale il 27,4%, mentre salgono al 50% in economia e al 49,5% in architettura e ingegneria civile. Anche in ambito medico-sanitario, dove la presenza femminile al 69,4% è più alta, la rappresentanza nelle posizioni apicali resta minoritaria.
Negli ultimi dieci anni, inoltre, l’ingresso femminile nei corsi tecnici non mostra un’accelerazione significativa: in ingegneria la quota di studentesse è passata dal 30,5% del 2016 al 31,5% del 2024, un avanzamento minimo; rispetto al 2010, quando erano il 26,7%, l’aumento a 28,1% appare positivo ma lento. E tale lentezza contribuisce a prolungare nel tempo l’asimmetria tra percorsi formativi e professioni più remunerative.
Anche a parità di titolo di studio emergono differenze retributive. Un ingegnere informatico a tre anni dalla laurea guadagna in media 2.001 euro netti al mese, mentre una collega si ferma a 1.866 euro, cioè 135 euro in meno ogni mese. Una tendenza che riflette una sottovalutazione sistemica delle competenze femminili anche a parità di ruolo.
Nel settore sanitario, pur essendo le donne il 60% dei medici ospedalieri, tra gli over 60 la loro presenza scende al 33%, un dato che racconta la lunga esclusione delle donne dalla formazione medica nelle generazioni precedenti. Oggi, però, questo squilibrio produce effetti diretti sulle posizioni apicali: i primari uomini negli ospedali italiani rappresentano ancora il 77%, mentre le donne sono ferme al 23%.
Una parte significativa dello svantaggio femminile è legata alle modalità di impiego. Nel 2024 un lavoratore uomo su cinque ha lavorato part-time, mentre tra le donne l’incidenza è di una su due. E soprattutto, quasi il 50% del part-time femminile non è frutto di una scelta, ma di necessità familiari o mancanza di alternative contrattuali. La maternità resta infatti uno snodo cruciale: prima della nascita di un figlio, uomini e donne che svolgono lo stesso lavoro presentano salari simili; dopo, si apre un divario stabile intorno al 16%, che tende ad ampliarsi nel tempo.
Nel confronto europeo, l’Italia non è tra i Paesi con il part-time femminile più elevato: nel 2024 la quota è del 29,8%, poco sotto la media UE (32,7%) e inferiore a Francia (25,8%) e Spagna (20,9%). Tuttavia, è la natura del part-time a segnare la differenza: in Germania, dove il 48,5% delle donne lavora a orario ridotto, solo il 4,4% lo fa per necessità, mentre in Italia la quota di part-time involontario sfiora una donna su due.
Paesi come Svizzera (62,8% di occupate part-time), Paesi Bassi (60,5%) e Austria (51,5%) mostrano livelli di lavoro ridotto molto più alti, ma in contesti in cui servizi familiari, welfare e retribuzioni permettono alle donne di conciliare in modo più equilibrato lavoro e vita privata, trasformando il part-time in una scelta consapevole e non in un vincolo.
In Italia, invece, la questione centrale resta la libertà di decidere: la combinazione di settori meno pagati, carriere più lente, ostacoli culturali, squilibri nel carico familiare e part-time imposto continua a incidere in modo determinante sulla retribuzione delle donne lungo tutto l’arco della vita lavorativa. È una disparità che non si limita al salario annuale, ma si traduce in minori contributi, pensioni più basse e un persistente divario economico tra i generi.
Gloria Giovanditti
Gender pay gap, in Italia le donne guadagnano ancora il 29% in meno: pesano settori, carriere e maternità